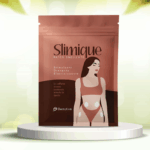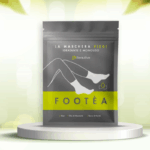Nei casi in cui uno o entrambi i genitori vengono accolti in una casa di riposo e non possiedono risorse economiche sufficienti a sostenere la spesa della retta, entra in gioco un sistema di obblighi legali molto definito. L’obbligo di pagare la retta nei confronti dei congiunti è regolato principalmente dall’articolo 433 del Codice Civile, secondo cui il compito di garantire le necessità “alimentari” (inteso in senso ampio, come mantenimento dei bisogni primari dell’individuo) spetta in primo luogo ai familiari più prossimi: coniuge, figli (senza distinzione tra legittimi, naturali o adottivi), genitori, fratelli e sorelle e, in assenza di questi, anche ad altri parenti come generi, nuore, suoceri e, solo in ultima istanza, nipoti diretti.
Quando nasce l’obbligo per i figli: i presupposti giuridici
Affinché i figli siano obbligati legalmente al pagamento della retta, devono sussistere alcune condizioni precise. In primo luogo, il genitore deve trovarsi in uno stato di bisogno accertato e non essere in grado di coprire autonomamente le spese della struttura. Questo avviene quando la pensione o altri redditi del genitore risultano insufficienti per saldare la retta mensile richiesta dalla struttura che lo ospita.
La quotaparte sanitaria (cioè le spese mediche e infermieristiche) viene in genere coperta dal Servizio Sanitario Nazionale se la struttura è pubblica, oppure da contributi parziali se la struttura è privata convenzionata. Tuttavia, la quota alberghiera, che rappresenta la componente relativa al soggiorno, ai servizi di pulizia, manutenzione e mensa, resta generalmente a carico dell’ospite, salvo casi in cui il Comune intervenga per situazioni di comprovato disagio sociale, previa verifica ISEE della famiglia.
Se la situazione economica del genitore non permette di coprire la quota totale, e neppure gli eventuali contributi comunali risultano risolutivi, a quel punto è previsto il coinvolgimento dei figli: questi possono essere chiamati a integrare la somma mancante sull’intero costo della retta. L’intervento dei figli avviene sia su richiesta diretta dell’ente pubblico che della struttura residenziale, ma può anche essere richiesto in giudizio dal genitore stesso attraverso un’azione volta a ottenere il pagamento degli “alimenti” nella misura necessaria a coprire la retta.
L’entità dell’obbligo e la situazione ISEE
L’obbligo dei figli non è incondizionato: si basa infatti sul principio della proporzionalità e della disponibilità economica degli stessi, ovvero in base alle reali possibilità economiche dei soggetti obbligati, secondo quanto stabilito dall’ordinamento e valutato considerando il reddito, il patrimonio e le esigenze personali e familiari. Non è previsto che un figlio debba impoverirsi o mettere a rischio il proprio nucleo familiare per far fronte alle spese della casa di riposo del genitore: la legge tutela infatti l’equilibrio tra le esigenze dei genitori anziani e quelle della famiglia dell’obbligato.
A tal fine, l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rappresenta lo strumento utilizzato dalla pubblica amministrazione per valutare il reddito complessivo della famiglia e determinare la ripartizione delle spese tra soggetto ospite e familiari. Sulla base dell’attestazione ISEE, il Comune stabilisce la quota eventualmente a carico dei figli e, ove presenti, anche degli altri obbligati indicati dal Codice Civile.
Le eccezioni: quando i figli non sono obbligati
L’esistenza di un redditometro oggettivo come l’ISEE serve anche a verificare l’eventuale esonero dal pagamento dei figli, nel caso in cui abbiano un tenore di vita modesto o siano privi di disponibilità tali da sostenere un ulteriore carico economico. Non possono quindi essere condannati al pagamento figli disoccupati, privi di redditi o già gravati da obblighi familiari rilevanti. In questi casi, se né il genitore, né i figli, né altri parenti obbligati possiedono mezzi sufficienti, a provvedere è il Comune di residenza.
Occorre precisare che la protezione per i parenti non si esaurisce al primo grado: se il figlio non è in grado, si passa ai successivi nella scala delle priorità, coinvolgendo eventualmente fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri, suocere e infine nipoti solo se non vi sono altri obbligati prossimi. L’obbligo, tuttavia, resta sempre soggetto a valutazione della rispettiva possibilità contributiva.
Obblighi contrattuali, azioni civili e controversie
Quando una persona viene ammessa in una struttura, può capitare che la casa di cura chieda fideiussione o una dichiarazione di garanzia al momento dell’ingresso: spesso i figli o i parenti si trovano così ad accettare obbligazioni di pagamento anche in assenza di reale possibilità contributiva. Tuttavia, la legge distingue tra obbligo morale e obbligo giuridico: solo quest’ultimo nasce in caso di reale impossibilità economica dell’anziano e previa verifica della posizione finanziaria dei congiunti.
Se la struttura non riceve i pagamenti dovuti, può attivare procedure di recupero crediti anche nei confronti dei figli, qualora risultassero obbligati secondo la normativa. Inoltre, il genitore in stato di bisogno può citare in giudizio i figli affinché un giudice stabilisca l’entità della somma dovuta nella forma di alimenti, che corrisponde al necessario per garantire l’assistenza minima vitale, e non alla totalità delle spese di soggiorno, se queste eccedono le sue possibilità.
La differenza tra obbligo alimentare e obbligo civile
È importante distinguere tra obbligo alimentare e obbligazione civile ordinaria. L’obbligo alimentare scatta soltanto nei casi di bisogno, non è automatico e non prevede l’obbligo di copertura integrale di tutte le spese. Il diritto agli alimenti consiste nel diritto a ottenere quanto basta per la sopravvivenza dignitosa, non un livello di comfort superiore a quello garantito dal minimo vitale di assistenza.
Strutture pubbliche, private e convenzionate
In Italia esistono varie tipologie di strutture per anziani: pubbliche, private e convenzionate. Le strutture pubbliche spesso offrono costi ridotti e maggiore copertura sanitaria, ma i tempi di accesso possono essere molto lunghi e i posti limitati. Le strutture private sono più care, ma più flessibili in accoglienza; quelle convenzionate, invece, prevedono copertura parziale da parte del Servizio Sanitario Nazionale e del Comune, lasciando una quota residuale a carico della famiglia o del singolo ospite.
In tutte queste situazioni, l’intervento dei figli scatta solo alla presenza di tutti i requisiti di legge e dopo attente verifiche istituzionali. Le migliori strutture offrono supporto anche nelle procedure amministrative, guidando la famiglia nella presentazione della documentazione ISEE e nell’individuazione delle possibili forme di contributo pubblico.
La normativa in materia si fonda dunque su una logica di solidarietà familiare che tutela sia il diritto degli anziani a un’assistenza dignitosa sia il diritto dei familiari a non subire un aggravio economico insostenibile. Gli obblighi sono chiari, ma sempre soggetti a una valutazione personalizzata, equilibrata e supportata da opportuni strumenti di verifica economica.